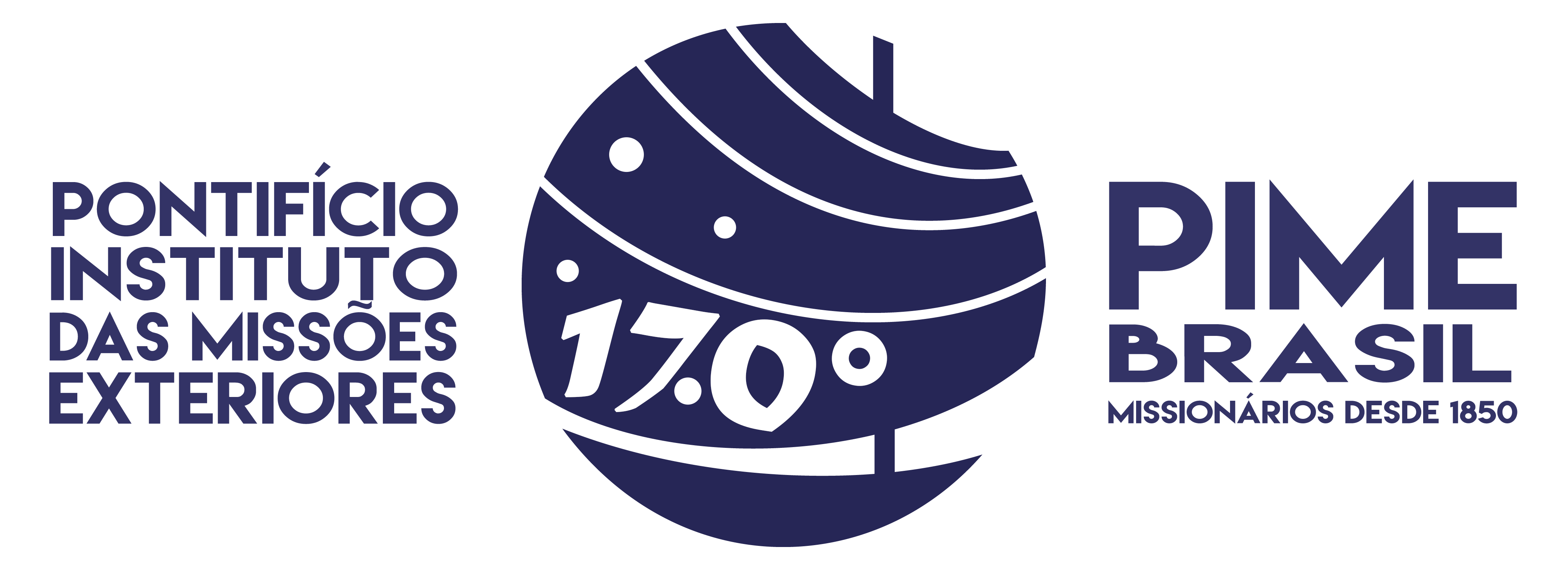I Labubu cuciti nelle campagne e il boom del lavoro precario delle donne in Cina
Dai pupazzetti divenuti un fenomeno globale alle grandi fabbriche tecnologiche e al settore del delivery, va sempre più diffondendosi in Cina un sistema che si regge sulla capacità di trasformare bisogni individuali e obblighi familiari in una disponibilità al lavoro praticamente senza limiti. Con le donne stesse spinte ad abbandonare contratti stabili (e garantiti solo sulla carta) per passare a forme di impiego temporaneo e stagionale.
Milano (AsiaNews) - Nelle zone industriali della provincia dell’Henan migliaia di donne cuciono vestiti in miniatura per i pupazzetti Labubu, il fenomeno commerciale cinese dell'anno. Molte hanno superato i cinquant'anni e lavorano undici ore al giorno in fabbrica, per poi continuare altre due o tre ore come operaie a cottimo, allacciando lacci alle scarpe dei pupazzi cuciti. Guadagnano solo pochi centesimi per pezzo, ma la maggior parte di loro non è esposta a una pressione finanziaria talmente grave da giustificare tale lavoro aggiuntivo. Alcune descrivono la loro decisione come una forma di dipendenza che le porta a cercare un senso di valore personale attraverso l’iperlavoro, in un contesto in cui l’ansia dell’invecchiamento le induce a moltiplicare le ore davanti alla macchina da cucire per sentirsi ancora all’altezza.
La situazione cambia radicalmente nelle grandi fabbriche del settore tecnologico, dove la motivazione non è più la ricerca di un reddito aggiuntivo o di un ruolo sociale, ma la necessità di raggiungere un salario che, senza straordinari, non copre nemmeno le spese essenziali. Questa dinamica trova la sua manifestazione più evidente negli stabilimenti Foxconn di Zhengzhou, la più grande base mondiale per l’assemblaggio di iPhone, dove la pressione produttiva e le aspettative di rendimento raggiungono livelli tali da rendere ancora più netta la distanza tra ciò che le lavoratrici sperano di ottenere e le condizioni reali in cui si trovano a operare. In questo contesto le cosiddette "Foxconn Moms" scelgono di abbandonare contratti stabili, completi di assicurazioni e benefit, per passare a forme di impiego temporaneo e stagionale. Lavorano alcuni mesi durante i picchi produttivi, si dimettono al termine della stagione e l'anno successivo rientrano nella stessa fabbrica come nuove assunte. Questo schema finisce per avvicinare il lavoro in fabbrica a una forma di occupazione frammentata e intermittente, con la particolarità che, nonostante la discontinuità, il luogo di lavoro resta formalmente lo stesso.
Il meccanismo che spiega questa apparente contraddizione si trova nella struttura salariale. Il salario base nelle fabbriche Foxconn è fissato al minimo legale, circa 1.900 yuan al mese, da cui vanno sottratte detrazioni obbligatorie che erodono ulteriormente la paga. Senza straordinari restano poche centinaia di yuan, troppo poco per giustificare la lontananza dalla famiglia. Gli straordinari diventano così l'unico modo per raggiungere uno stipendio accettabile, che può arrivare fino a 6.000 yuan nei mesi di picco, ma Foxconn li concede come premio selettivo solo a chi mantiene ritmi impeccabili e nessun errore. Chi rimane escluso si ritrova con un salario insufficiente e lascia il posto, sostituito rapidamente da nuove reclute provenienti dalle campagne vicine. La libertà apparente di scegliere forme di impiego più flessibili maschera un meccanismo che comprime i salari di base e costringe le lavoratrici a competere per accumulare ore aggiuntive.
Produzione e maternità, il doppio sfruttamento delle lavoratrici
Dietro questa apparente fluidità del lavoro si nasconde una divisione che colpisce soprattutto le lavoratrici. Nelle fabbriche di assemblaggio elettronico l’accesso ai ruoli tecnici meglio retribuiti continua a privilegiare gli uomini, mentre chi entra nelle mansioni più faticose e ripetitive sono in gran parte operaie con alle spalle anni di esperienza non riconosciuta. Con prospettive salariali più limitate già in partenza, molte accettano turni aggiuntivi, pause non pagate o cambi improvvisi di orario senza poter realmente negoziare. Ciò che viene presentato come lavoro volontario si traduce, nei fatti, in una necessità quotidiana.
Una dinamica analoga la si riscontra nel settore del delivery, dove negli ultimi due anni le rider femmine sono aumentate del 35%, in gran parte donne sposate con figli e la cui età media è più alta di quella dei colleghi maschi. Guadagnano meno, sono penalizzate dagli algoritmi che privilegiano velocità e disponibilità notturna e, per compensare questi svantaggi, lavorano anche nei giorni che dovrebbero essere di riposo. I limiti fisici e di sicurezza si intrecciano così con un modello di remunerazione che accentua le disuguaglianze di genere. A questa pressione si somma il peso crescente di quella che i sociologi chiamano la riproduzione sociale. Nelle campagne della provincia dell’Henan, il costo del matrimonio, della casa e dell'auto richiesti come dote raggiunge cifre sproporzionate rispetto ai redditi agricoli, mentre la progressiva chiusura delle scuole primarie di villaggio ha costretto le famiglie a rivolgersi a istituti privati con rette sempre più onerose. Le spese per l'istruzione e l'assistenza agli anziani rendono indispensabile la disponibilità di un reddito stabile, e per molte madri questo significa lavorare in fabbrica.
Ma la cultura dell'accudimento intensivo, ormai radicata anche nelle aree rurali, impedisce alle madri di lavorare lontano da casa in modo continuativo. Per questo molte di loro scelgono partenze stagionali, affidano i figli ai suoceri solo nei mesi estivi quando la scuola è chiusa, cercano di mettere da parte qualche risparmio durante i periodi di maggiore domanda e poi rientrano in autunno. Questo movimento ciclico, modellato dai tempi della fabbrica e dalle responsabilità familiari, genera un turnover altissimo che offre alle aziende una forza lavoro sempre disponibile e riciclabile, finendo così per rafforzare il sistema. La manodopera femminile resta indispensabile ma, allo stesso tempo, facilmente sostituibile, una condizione che rende impossibile qualsiasi forma di stabilità o solidarietà collettiva.
Oltre la narrazione ufficiale
Queste forme di mobilità intermittente non sono un fenomeno isolato, ma il risultato di un cambiamento più profondo. La delocalizzazione delle fabbriche dalla costa verso le province interne, avviata attorno al 2010, ha infatti posto le basi del nuovo regime di precarietà. L'apertura dello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, con centinaia di migliaia di addetti, ha segnato l'avvio di una trasformazione poi estesa a molte altre province. La scelta di collocare le fabbriche a ridosso dei villaggi rurali ha reso più semplice per le donne con figli entrare nel lavoro industriale, favorendo un afflusso costante di nuova manodopera e modificando in profondità la composizione della forza lavoro. Questa trasformazione si è sovrapposta alla campagna statale per la formalizzazione del lavoro migrante. Dal 2014 il governo ha limitato l'impiego di personale temporaneo e promesso maggiori tutele, ma i contratti formali restano in larga misura inaccessibili: le detrazioni obbligatorie assorbono una parte consistente del salario di base e i benefit richiedono anni di residenza continuativa nella stessa città, una condizione irrealistica per chi si muove stagionalmente tra fabbrica e villaggio. Le garanzie esistono sulla carta, non nella vita quotidiana delle lavoratrici.
La medesima struttura si ripresenta in forme solo apparentemente diverse. Che si tratti delle fabbriche che producono accessori per i pupazzetti Labubu, degli impianti di assemblaggio elettronico o del settore del delivery urbano, il principio rimane identico: il sistema si regge sulla capacità di trasformare bisogni individuali e obblighi familiari in una disponibilità al lavoro praticamente senza limiti. Ciò che viene presentato come scelta personale, come margine di flessibilità o come occasione di guadagno nasconde invece un’organizzazione che assorbe ogni spazio lasciato libero dalle politiche salariali e dall’assenza di tutele, e che utilizza le donne come ammortizzatore continuo delle fluttuazioni produttive.
Lo scarto tra narrazione e realtà definisce così la condizione attuale del lavoro femminile in Cina. La precarietà viene presentata come flessibilità e la dipendenza economica come autonomia. Dietro l'immagine dell'empowerment si intravede una strategia di accumulazione fondata sulla segmentazione della forza lavoro e sull'intreccio tra produzione e cura. Le lavoratrici restano intrappolate in questo equilibrio fragile, sospese tra pressioni economiche sempre più forti e aspettative sociali che continuano a vincolarle al ruolo di madri e custodi della famiglia.
“LANTERNE ROSSE” È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CINA.
VUOI RICEVERLA OGNI GIOVEDI’ SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK
02/02/2018 08:37
19/02/2018 12:39