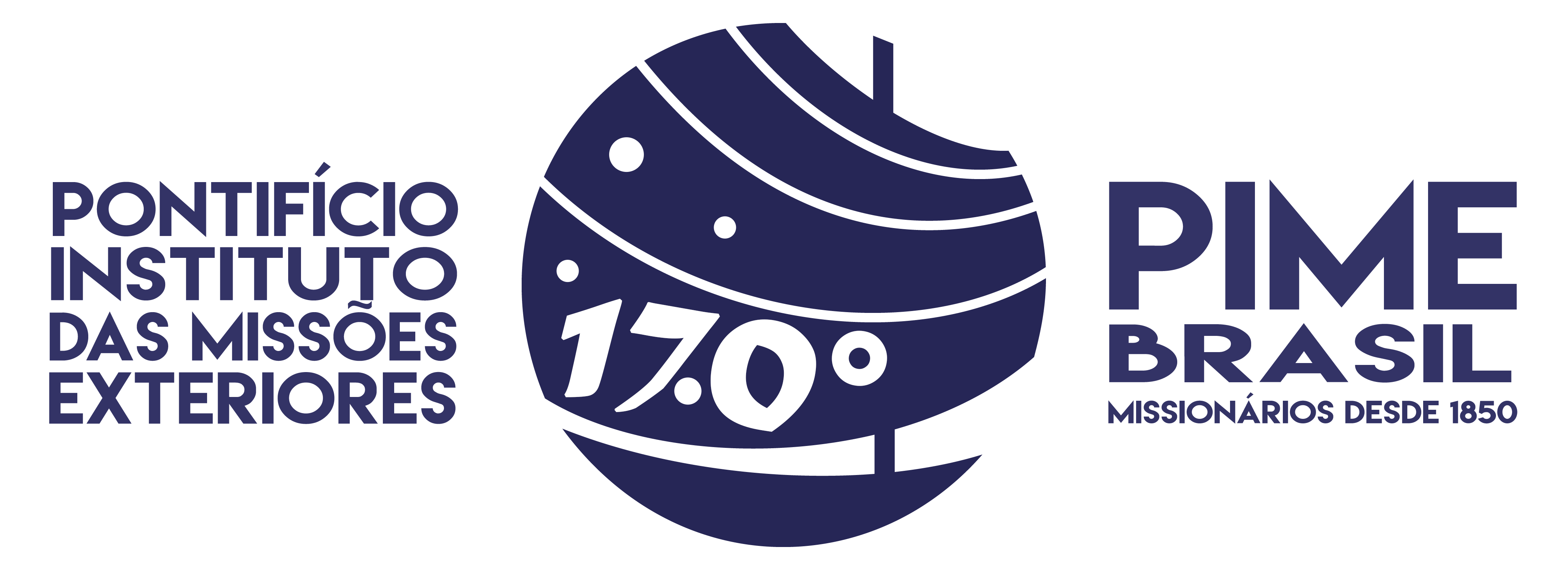Il rabbino Milgrom: 'Leggo i nomi dei palestinesi uccisi a Gaza contro la crisi morale di Israele'
Religioso riformato e attivista per i diritti umani Jeremy Milgrom parte dalla lettura quotidiana dei nomi delle vittime palestinesi per denunciare la deriva morale, politica e religiosa di Israele: una società frammentata, segnata dall’estremismo, dall’uso distorto dei testi biblici e dalla paura. I rapporti di forza che nella società israeliana stanno cambiando e l'invito a recuperare la tradizione della misericordia per ascoltare “il grido degli oppressi”. Prima che sia troppo tardi.
Milano (AsiaNews) - Jeremy Milgrom, rabbino riformato e attivista per la pace, stringe fra le mani un volume di oltre mille pagine, pieno solo di nomi. “Quando l’ho visto appoggiato sul tavolo in una chiesa a Bologna, stavo per piangere”, racconta. Il volume si intitola I nomi della memoria del genocidio a Gaza. Un’ingiustificabile conta e un appello in sospeso, curato da Yassine Baradai, ed elenca uno per uno i 58.383 palestinesi uccisi tra il 7 ottobre 2023 e il 15 luglio 2025, accompagnati solo dalle date di nascita e di morte.
“Mi sono detto che non volevo tornare in Israele senza questo libro. Lo porterò con me, cercherò di leggerlo ogni giorno, e di condividerlo con la mia famiglia e i miei amici. Ogni giorno leggeremo qualche nome. E forse, se leggiamo i nomi, smetteremo di aggiungerne altri. Smetteremo il massacro, smetteremo di versare sangue. Perché quando abbiamo detto ‘mai più’, deve valere per chiunque, non solo ‘mai più per noi ebrei’”, aggiunge il rabbino durante un evento organizzato il 12 novembre dalla parrocchia San Fedele di Milano.
Jeremy Milgrom è nato negli Stati Uniti, ha studiato al Jewish Theological Seminary di New York e si è trasferito a Gerusalemme nel 1968, a 15 anni. Negli anni ’70 ha prestato servizio nell’esercito israeliano, compresa la guerra dello Yom Kippur del 1973, in cui ha perso il suo migliore amico. Col tempo è diventato un pacifista dichiarato, impegnato per i diritti umani e il dialogo con i palestinesi. È stato tra i fondatori dell’organizzazione “Rabbis for Human Rights” - che oggi è in prima linea nel contrastare le violenze dei coloni in Cisgiordania - e dell’iniziativa interreligiosa “Clergy for Peace”, che riunisce leader cristiani, musulmani ed ebrei.
Per capire cosa sta succedendo oggi in Israele, bisogna tornare a un noto discorso, quello dell'ex presidente Reuven Rivlin del 2015 sulle “quattro tribù” di Israele. Rivlin parla di quattro gruppi principali: ebrei laici, ebrei nazional-religiosi, ebrei ultraortodossi e cittadini palestinesi israeliani. Gruppi che vivono fianco a fianco, ma quasi mai insieme. Sono persone che ancora oggi “hanno scuole proprie e spesso non si incontrano. Gli arabi palestinesi con cittadinanza israeliana e molti ultraortodossi non partecipano ai processi di integrazione attraverso l’esercito. Quindi circa il 50% della società israeliana non passa per l’esperienza che, nel bene e nel male, crea un linguaggio comune: il servizio militare”, spiega Milgrom.
Gli ultimi due anni, con la guerra a Gaza e le tensioni in Cisgiordania, hanno prodotto una forma di unità che fa paura: “La guerra tiene insieme la società in un modo terribile. È quello che fanno i governi che vanno in guerra: cercano di unificare, di soffocare il dissenso. Una delle quattro tribù è stata silenziata in questi anni: i palestinesi con cittadinanza israeliana, circa il 21% della popolazione. Sono intimiditi, perseguiti, parlano pochissimo per paura”.
La frattura non è solo tra ebrei e palestinesi, ma oggi riguarda lo stesso mondo ebraico. Milgrom racconta un episodio personale che sintetizza bene questa deriva: “Il figlio della mia compagna è un soldato combattente. È cresciuto in un ambiente laico e liberale. Ma da quando è tornato a casa dal servizio militare non lo riconosco più: i suoi commilitoni di destra gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Ed è tragico vedere come i segmenti più estremisti (non solo i coloni, ma soprattutto loro) stiano trascinando tutti verso destra”.
È un processo politico che arriva da lontano e si riscontra nelle biografie personali di tutti, politici compresi: “Guardate Rivlin. Quando era candidato alla presidenza, Netanyahu fece di tutto per impedirne l’elezione, arrivando perfino a ipotizzare di abolire la carica pur di non farlo diventare presidente. La presidenza in teoria è una carica non politica, ma la ‘tribù di Netanyahu’ era pronta a smantellarla per mantenere il controllo. È un esempio di come diversi poteri in Israele stiano erodendo la democrazia. Siamo in una situazione molto delicata e precaria”.
Sulla soluzione politica, Milgrom è netto: “Da almeno vent’anni non credo più che la soluzione dei due Stati sia possibile, né desiderabile. Nel modello di cui si parlava, i palestinesi avrebbero ottenuto poco: una specie di Hong Kong di grattacieli, senza terra per i contadini, senza una vera economia, senza la possibilità di tornare nei villaggi e nelle città dentro Israele. La soluzione di uno Stato, invece - spiega ancora il rabbino -, significherebbe smettere di parlare di ‘Stato ebraico’ e parlare di uno Stato di tutti i suoi residenti, uno Stato per due popoli. È una rivoluzione per cui la maggior parte degli ebrei israeliani non è ancora pronta. Siamo molto lontani”.
E poi aggiunge: “Il motivo per cui i sionisti rifiutano di considerare una soluzione a uno Stato, che sarebbe quella razionale, è che sono congelati nel passato, ancora legati all’idea colonialista di essere arrivati in una terra vuota. A questo si sommano paure legate alla resistenza armata palestinese, che permettono agli israeliani di leggere tutto attraverso la lente della loro (in)sicurezza”.
Per Milgrom, queste paure si intrecciano con “atteggiamenti esclusivisti basati sul comandamento biblico di eliminare ogni traccia dei Cananei idolatri”, un’interpretazione che, precisa, “non dovrebbe valere, perché l’ebraismo considera l’Islam un monoteismo evoluto e non idolatrico”.
“Testi genocidari tradizionali, come quello su Amalek, e scenari apocalittici sono stati riattivati”, prosegue, “insieme al messianismo estremo diffuso da Tzvi Yehudah Kook (il rabbino fondatore della corrente nazionalista religioso ndr) e dai suoi discepoli. Tutto questo, combinato con l’islamofobia occidentale, lascia pochissimo spazio in Israele alla visione universalista dell’ebraismo ottocentesco, che sopravvive solo nella diaspora”.
Eppure una speranza c’è: “Nella diaspora cresce un ebraismo non-, anti- o post-sionista portato avanti da intellettuali e rabbini che sostengono iniziative come Jewish Voice for Peace o Rabbis for a Ceasefire - precisa ancora -. È ciò che mi fa sperare nel futuro dell’ebraismo, perché quello che vedo svilupparsi in Israele è un ebraismo tossico”.
In particolare, in questo paesaggio politico, per Jeremy Milgrom è inquietante il modo in cui testi biblici e midrashici (la midrash è l’esegesi biblica ebraica) vengono utilizzati come giustificazione religiosa per la violenza. “C’è un racconto su re Saul, per esempio, che fa massacrare i sacerdoti di Nob perché avevano dato da mangiare a quello che lui considerava un nemico. Il midrash dice che Saul, in passato, era stato troppo misericordioso con i malvagi, e quindi conclude affermando che se sei compassionevole con i crudeli, finirai per essere crudele con i misericordiosi”.
“Oggi - spiega il rabbino - questa frase viene citata ovunque. Diventa la prova che non devi essere misericordioso con ‘i cattivi’, perché sennò tradisci ‘i buoni’. Ma come puoi costruire una religione su questo? Come educhi le persone? Educhi alla crudeltà? Dai alla gente una scusa per essere barbara? Eppure è quello che sta succedendo”.
Un altro testo chiave è quello che il midrash applica alla scena in cui Saul perseguita David, e David lo risparmia nella grotta: “Il midrash dice che se qualcuno ti sta inseguendo per ucciderti, devi essere tu a ucciderlo per primo. Oggi viene usato come dottrina della ‘guerra preventiva’: non aspettare l’attacco, colpisci per primo. Ma nel racconto biblico David non lo fa. Potrebbe uccidere Saul, e non lo fa. Il senso del testo è l’opposto di ciò che ne viene tratto”.
E in ogni caso, anche se ci sono testi di particolare durezza nella Bibbia, “siamo anche stati educati a chiamare Dio ‘Dio di misericordia’. Diciamo che dobbiamo imitarlo: se Dio è misericordioso, anche noi dobbiamo esserlo. I musulmani cominciano ogni preghiera con ‘Bismillah al-Rahman al-Rahim’, che significa ‘Nel nome di Dio, il Clemente e il Misericordioso’. Quando lo diciamo, lo imitiamo. È così che Dio vuole che funzioniamo”.
Per Milgrom, il problema quindi non è la Bibbia in sé, ma la combinazione con un contesto di paura e nazionalismo: “Per 1.800 anni gli ebrei non hanno avuto eserciti né strumenti di violenza organizzata. La tradizione pratica è stata una tradizione di non-violenza. Con il nazionalismo, in un contesto di conflitto, buttiamo via la nostra storia di non-violenza e frughiamo nei testi per trovare giustificazioni teologiche alla violenza”.
Un’operazione preoccupante voluta dall’estrema destra, ma che in realtà non ha niente a che vedere con le tradizioni ebraiche: “Pensa ai ‘Giovani delle colline’, i ragazzi estremisti in Cisgiordania: quello che fanno di Shabbat - violenza, incendi, aggressioni - è chiaramente una violazione dello Shabbat. Eppure i rabbini non intervengono, alcuni li incoraggiano.”
Milgrom torna alla Bibbia per sostenere la non violenza. Parte dal capitolo 23 dell’Esodo in cui “ci viene comandato di non opprimere la vedova, l’orfano e lo straniero. Il testo dice che, se li opprimiamo, loro grideranno a Dio, Dio ascolterà il loro grido e farà sì che i nostri figli diventino orfani e le nostre mogli vedove. È forse il versetto più terrificante di tutta la Bibbia”.
“Io non voglio che accada. Allora dico: prima che il loro grido arrivi a Dio, deve arrivare ai politici. Dobbiamo fare in modo che non sia ‘lassù’ a intervenire, ma ‘quaggiù’, dove possiamo salvare vite e ottenere giustizia”. Il rabbino cita anche Caino e Abele: “Quando Dio chiede a Caino: ‘Dov’è tuo fratello Abele?’, lui risponde: ‘Sono forse io il custode di mio fratello?’ La Bibbia non risponde. La domanda resta aperta. Siamo noi a doverla completare: sì, siamo custodi gli uni degli altri. Se non rispondiamo così, non importa quanto belle siano le nostre chiese o le nostre sinagoghe”.
Alle citazioni bibliche aggiunge uno slogan israeliano degli anni ’90: “C’era una canzone molto popolare che diceva: ‘Tutti parlano di pace, nessuno parla di giustizia’. Trent’anni fa. Oggi parliamo a malapena di pace, figuriamoci di giustizia.” Ma alla riflessione aggiunge una frase del predicatore americano Theodore Parker, resa celebre da Martin Luther King: “‘L’arco dell’universo morale è lungo, ma tende verso la giustizia.’ La storia ci metterà molto, ma alla fine la giustizia arriverà. Nel frattempo, dobbiamo fare tutto quello che possiamo: studiare, ascoltare, imparare”.
Poi torna al versetto che non lo lascia in pace: la minaccia contro chi opprime la vedova, l’orfano, lo straniero. “Io non voglio che i nostri figli diventino orfani e le nostre mogli vedove. Voglio che il loro grido arrivi a noi prima che arrivi a Dio. E che noi, finalmente, lo ascoltiamo”.