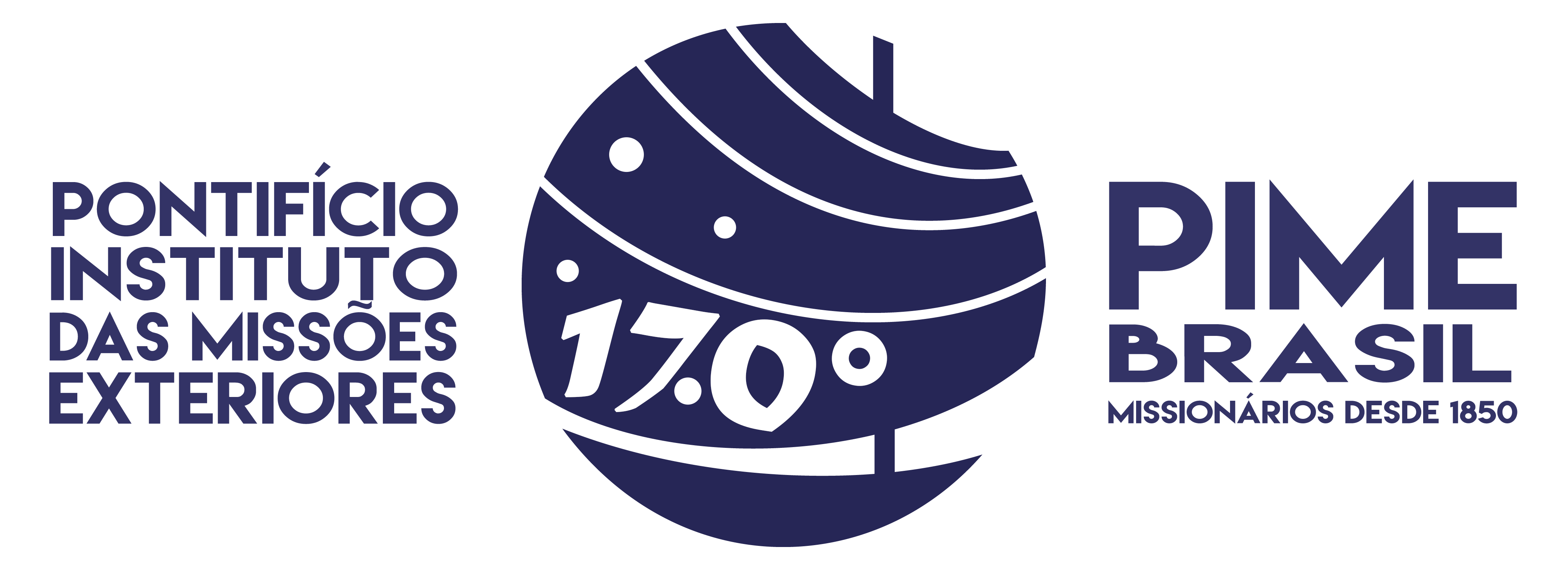Rohingya, il genocidio sotto processo ma senza parlare del Myanmar di oggi
Si apre alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja il caso di presunto genocidio commesso dall'esercito birmano contro i Rohingya nel 2017. Il procedimento, promosso dal Gambia, arriva dopo anni di inerzia internazionale, in un contesto oggi segnato da profondi stravolgimenti politici e militari in Myanmar. Il golpe del 2021, la guerra civile in corso e i ribaltamenti di alleanze sul terreno rendono il processo sempre più scollegato dalla realtà attuale.
L’Aia (AsiaNews/Agenzie) – Si è aperto oggi all'Aja alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite il caso sul presunto genocidio compiuto dall’esercito del Myanmar contro i Rohingya, gruppo etnico perlopiù di fede islamica concentrato nello Stato birmano occidentale del Rakhine.
Secondo Dawda Jallow, ministro della Giustizia del Gambia, che ha presentato il caso al tribunale Onu che si occupa delle controversie tra Stati, il Tatmadaw (l’esercito birmano) ha deliberatamente colpito il gruppo nel tentativo di eliminarlo: “Non si tratta di questioni esoteriche di diritto internazionale. Si tratta di persone reali, storie reali e un vero gruppo di esseri umani. I Rohingya del Myanmar. Sono stati presi di mira per essere annientati”.
Nel 2017 le violenze dei generali birmani, che oggi sono impegnati in una sanguinosa guerra civile, provocarono la fuga di circa 750mila Rohingya verso il vicino Bangladesh. Il colpo di Stato militare del primo febbraio 2021 e il conseguente conflitto hanno da allora impedito il ritorno degli sfollati. Diversi giovani che, al contrario, sono rimasti in Rakhine, negli ultimi anni sono stati costretti a combattere nelle fila dell’esercito contro l’Arakan Army, una delle milizie che compongono la resistenza anti-golpe e che hanno riconquistato diverse aree del Rakhine. Si tratta di un rovesciamento della situazione di cui le autorità giudiziarie non si occuperanno.
Il processo è il primo caso di genocidio di cui la Corte internazionale di giustizia si occupa integralmente in oltre un decennio, ed è molto probabile che l’esito avrà ripercussioni che andranno oltre il Myanmar, influenzando anche la petizione del Sudafrica contro Israele per le modalità di conduzione della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza.
Una missione conoscitiva delle Nazioni Unite del 2017 concluse che i generali birmani avevano condotto anche “atti di genocidio”. Il governo del Myanmar del tempo, guidato dalla leader democratica Aung San Suu Kyi, respinse il rapporto, affermando che l’azione militare faceva parte di una legittima campagna antiterrorismo in risposta agli attacchi dei gruppi armati Rohingya.
A dare inizio alle violenze furono infatti alcuni attacchi dell’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) contro alcune basi dell’esercito birmano. L’ARSA ha poi continuato a macchiarsi di crimini e omicidi mirati, soprattutto nei campi profughi Rohingya di Cox’s Bazar, in Bangladesh. Nel 2021, per esempio, alcuni uomini armati uccisero Mohib Ullah, leader musulmano molto popolare che aveva fondato la Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, associazione che si batte per i diritti degli sfollati. Negli ultimi anni le autorità del Bangladesh hanno arrestato diversi uomini dell’ARSA, incluso il capo del gruppo, Ataullah Abu Ammar Jununi.
Nel 2017 la stessa Aung San Suu Kyi – incarcerata dall’esercito dopo il golpe del 2021 – era stata accusata di aver spalleggiato l’esercito e di essere quindi in parte responsabile del “genocidio” dei Rohingya. In realtà, il figlio minore, Kim Aris, e diversi commentatori birmani hanno più volte sottolineato che “la Signora” stesse cercando di evitare uno scontro diretto con i generali. Non è un caso che nel 2019 la premio Nobel per la Pace definì le accuse di genocidio presentate dal Gambia “incomplete e fuorvianti”. A confermare questa lettura sono stati ancora una volta gli eventi successivi: dal 2024 i capi del Tatmadaw hanno reclutato i combattenti dell’ARSA nel tentativo di sconfiggere l’Arakan Army, che a sua volta accusa l’ARSA di reclutare giovani con la forza e di prendere di mira anche i civili.
Mentre l’esercito birmano continua a negare le accuse di genocidio, il Governo di unità nazionale (NUG) – composto da legislatori del precedente governo in esilio – ha dichiarato di aver “accettato e accolto con favore” la giurisdizione del tribunale ONU, aggiungendo di aver “ritirato tutte le obiezioni preliminari” precedentemente presentate sul caso. Il NUG, in una inversione di posizione politica, ha riconosciuto i propri errori, che, a suo dire, “hanno permesso gravi atrocità” contro i Rohingya. Nella dichiarazione rilasciata prima dell’udienza i legislatori hanno utilizzato proprio questo nome, che la stessa Aung San Suu Kyi si era rifiutata di usare. Di norma, infatti, i Rohingya in Myanmar vengono chiamati “bengalesi”, nel tentativo di dipingerli come migranti originari del Bangladesh che non hanno diritto alla cittadinanza birmana.
D’altra parte, diversi membri della popolazione Rohingya che hanno subito persecuzioni sperano che il caso possa portare giustizia al loro popolo: “Vogliamo giustizia e pace”, ha affermato per esempio Janifa Begum, 37 anni, madre di due figli, ad Al Jazeera. “Le nostre donne hanno perso la loro dignità quando la giunta militare ha lanciato lo sfratto. Hanno bruciato villaggi, ucciso uomini e le donne sono diventate vittime di una violenza diffusa”.
“Speriamo in un risultato positivo che dica al mondo che il Myanmar ha commesso un genocidio, che noi ne siamo vittime e che meritiamo giustizia”, ha commentato invece alla Reuters Yousuf Ali, un rifugiato Rohingya di 52 anni che ha dichiarato di essere stato torturato dall’esercito del Myanmar. Le udienze presso la Corte internazionale di giustizia dureranno tre settimane, ma le varie sessioni saranno chiuse al pubblico e ai media per motivi di riservatezza e privacy.
12/12/2019 13:31
23/01/2020 14:15





.jfif)







.jfif)