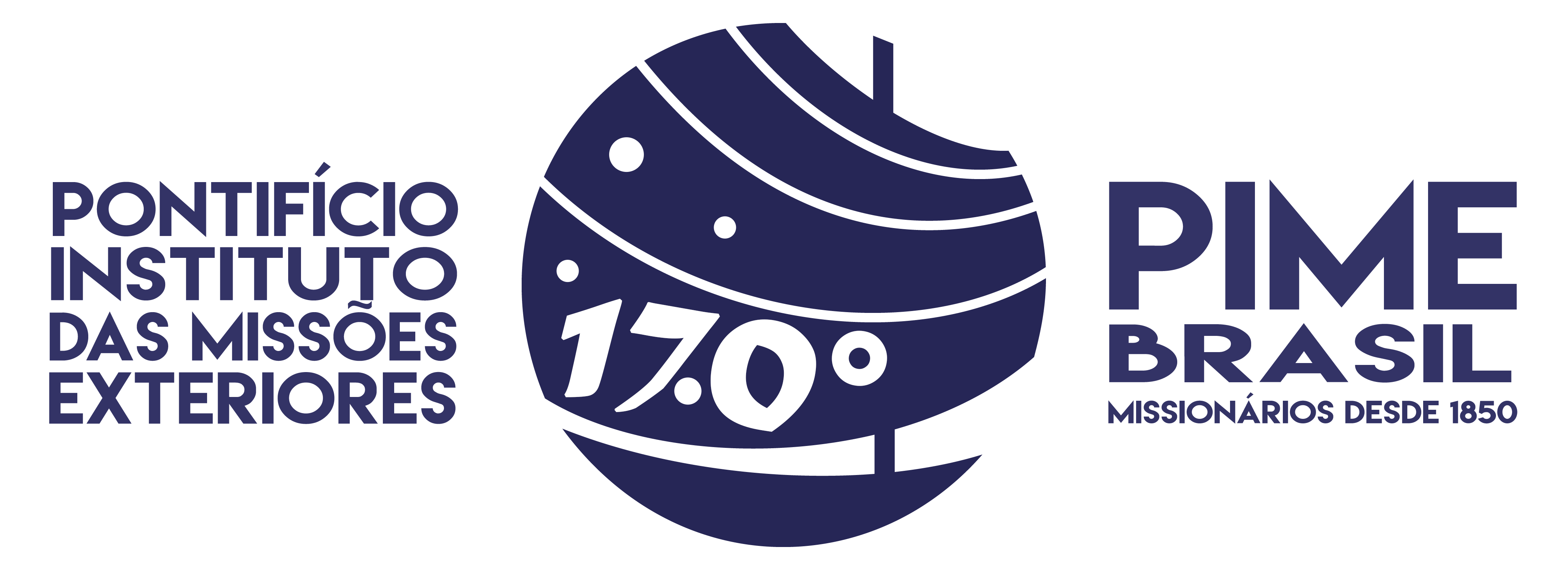Seoul: privilegi e politiche governative bloccano la mobilità sociale
Il tasso di disoccupazione giovanile sarebbe attorno al 30%. Chi parte senza aiuti rimane escluso da un sistema che premia soprattutto l’eredità. Il debito è diventato “condizione strutturale” di accesso a istruzione, lavoro e alloggio. E quando le banche chiudono le porte, molti finiscono nelle mani degli usurai. Un costo umano crescente in termini di suicidi e malessere.
Milano (AsiaNews) - In Corea del Sud la mobilità sociale è ormai un’eco lontana. Quello che potrebbe sembrare un semplice passaggio di testimone tra generazioni nasconde invece un ordine sociale bloccato, in cui l’ereditarietà del privilegio ha finito per sostituire il merito, sostenuta da politiche che proteggono i patrimoni e da un accesso al credito che favorisce chi è già ricco. Ne deriva una società in cui il destino individuale si decide soprattutto alla nascita e in cui la posizione sociale iniziale tende a cristallizzarsi, limitando l’ampiezza delle traiettorie possibili.
La frattura più significativa riguarda i nati intorno al 1990, figli della seconda ondata di baby boomer coreani. A differenza della generazione precedente, che ha potuto costruire carriere autonome durante il boom economico mondiale del commercio, questi giovani sono entrati nel mercato del lavoro nel 2015, proprio mentre si consumava quella che gli economisti hanno definito “la scogliera occupazionale”. L’innalzamento dell’età pensionabile a 60 anni nel 2016 ha spinto grandi imprese e istituzioni pubbliche a bloccare le nuove assunzioni, mentre la de-industrializzazione e la persistenza di un mercato del lavoro duale hanno reso sempre più rari i posti stabili e ben retribuiti. Alcune analisi collocano il tasso reale di disoccupazione giovanile oltre il 30%.
Il divario patrimoniale mostra con chiarezza quanto la ricchezza si sia concentrata. Tra i cinquantenni il quinto più ricco possiede oltre cinquanta volte più del quinto più povero e tra gli over sessanta il rapporto supera le settanta volte. Il dato più significativo emerge tra i ventenni, una fascia in cui i redditi sono relativamente simili ma le differenze patrimoniali diventano enormi. La fascia più ricca possiede quasi quaranta volte quella più povera e questa sproporzione nasce in gran parte dai trasferimenti familiari. Chi proviene da famiglie con mezzi riceve un appartamento, il sostegno necessario per un’istruzione privata e sbocchi professionali, mentre chi parte senza aiuti rimane escluso da un sistema che premia soprattutto l’eredità.
L’evoluzione del mercato immobiliare ha irrigidito ulteriormente questa struttura. A Seoul i prezzi sono saliti fino a rendere l’acquisto impraticabile per chi ha uno stipendio medio e il sistema jeonse, che richiede un deposito molto elevato, ha aumentato la distanza tra chi può contare sul capitale dei genitori e chi non ha garanzie. Le politiche pubbliche non hanno invertito la tendenza, poiché gli interventi nati per contenere la speculazione hanno solo rallentato le transazioni senza ottenere una reale diminuzione dei prezzi. Ne è nato un mercato che mantiene intatti i patrimoni già formati e che innalza sempre di più la soglia di accesso per i giovani.
Il debito come condizione strutturale
Questa dinamica immobiliare si intreccia con un fenomeno più ampio. Il debito privato ha smesso di essere uno strumento finanziario occasionale per diventare la condizione strutturale dell’accesso a istruzione, lavoro e alloggio. Il debito delle famiglie sudcoreane ha raggiunto il livello più alto mai registrato, equivalente al 91% del prodotto interno lordo, contro una media dei paesi sviluppati del 68%. Il rapporto tra debito e reddito annuale del singolo coreano è più del doppio rispetto alla Francia.
Per i ventenni la situazione è ancora più grave e il debito medio supera ampiamente la metà del reddito annuale. Queste cifre fotografano una generazione che accumula debiti prima ancora di entrare stabilmente nel mercato del lavoro. Tra i ventenni il tasso di insolvenza è il più alto e oltre 60mila giovani risultano ormai in default cronico, con il rischio di essere spinti verso forme di credito illegale.
La costruzione di un curriculum competitivo assorbe in media 440mila won al mese (circa 260 euro) e quasi la metà dei laureati in cerca di lavoro frequenta corsi privati per ottenere certificazioni linguistiche o accumulare esperienze utili alla selezione. Oltre il 70% afferma di sentirsi sotto pressione finanziaria per questi investimenti, spesso coperti con prestiti. Il meccanismo è un circolo vizioso, perché per aspirare a un impiego stabile occorre accumulare credenziali, ma questo percorso genera debiti che rendono ancora più necessario ottenere un posto di lavoro, che nel frattempo diventa sempre più difficile da trovare dato che le grandi aziende riducono le assunzioni di personale senza esperienza.
Quando le banche chiudono le porte, molti giovani finiscono nelle mani degli usurai. Circa il dieci per cento dei ventenni e dei trentenni ha già fatto ricorso a prestiti illegali, una quota che continua ad aumentare. Portali online come Daechulnara dovrebbero funzionare come piattaforme in cui chi ha bisogno di denaro riceve offerte da istituti di credito registrati, ma nella pratica a rispondere per primi sono gli operatori illegali, che propongono tassi annuali superiori al 3.000% a fronte di un limite legale del 20%. Le truffe basate sul furto di dati personali, molto diffuse in Corea, hanno aggravato ulteriormente la situazione, trascinando molte vittime ancora più a fondo nella spirale del debito.
Il caso più estremo di questa deriva è emerso nell’agosto 2025, quando decine di giovani coreani sono stati rimpatriati dalla Cambogia in manette. Erano stati attirati da offerte che promettevano stipendi elevati per lavori nel settore informatico, ma una volta arrivati erano stati costretti a partecipare a truffe online e sottoposti a violenze fisiche e psicologiche. Si sono ritrovati a essere vittime due volte, prima di un sistema economico che li aveva spinti alla disperazione e poi di reti criminali che avevano trasformato quella stessa vulnerabilità in una trappola.
L’erosione silenziosa del miracolo coreano
La pressione economica si traduce in un costo umano crescente. Nel 2024 in Corea del Sud sono state registrate quasi 15mila suicidi, che rappresentano ormai la principale causa di decesso tra le persone sotto i cinquant’anni. Il Paese continua a registrare uno dei tassi più alti tra i membri dell’Ocse e i segnali di malessere sono evidenti anche in termini di salute mentale, con un forte aumento dei disturbi depressivi e un numero crescente di giovani che arrivano al pronto soccorso per episodi di autolesionismo.
Parallelamente cresce la quota di giovani che si ritirano completamente dalla vita economica e sociale. Centinaia di migliaia di persone sotto i trent’anni risultano inattive, né impiegate né in formazione, e molte dichiarano di essersi semplicemente fermate dopo aver incontrato un mercato del lavoro ostile. La promessa secondo cui l’istruzione garantirebbe mobilità si è incrinata, perché una parte significativa di questi inattivi è laureata. La contraddizione è evidente perché, mentre l’occupazione generale migliora e alcuni settori crescono, le grandi imprese continuano a privilegiare profili già esperti e investono in automazione e intelligenza artificiale, riducendo ulteriormente lo spazio per chi dovrebbe entrare ora nel mondo del lavoro.
Questo gruppo di giovani si trova esposto a tre crisi che altrove tendono a manifestarsi separatamente, ma che in Corea si sovrappongono. Da un lato devono fare i conti con pressioni simili a quelle che conosciamo in Europa, dove un mercato del lavoro rigido fondato sull’anzianità si combina con un’alta disoccupazione giovanile e sistemi pensionistici sempre più fragili. Allo stesso tempo vivono dinamiche che ricordano gli Stati Uniti, perché l’intelligenza artificiale comincia a svalutare molte competenze specialistiche e il vantaggio salariale legato alla laurea si riduce. Su tutto ciò si innesta una disuguaglianza tipica delle economie emergenti, nelle quali ricchezza familiare e reti di conoscenze determinano l’accesso all’occupazione con logiche quasi feudali.
Il risultato è una società che continua a misurare il successo attraverso gli indicatori macroeconomici mentre allo stesso tempo vede sgretolarsi il tessuto sociale, che si fa sempre più debole. Il debito è il filo che tiene insieme questa contraddizione, divenuta ormai insostenibile. La Corea del Sud ha alimentato la propria espansione trasferendo tutti i costi della riproduzione sociale sugli individui e sulle famiglie, trasformando il debito in un elemento permanente dell’esistenza quotidiana. Il modello di sviluppo sudcoreano appare così come un esperimento di crescita privo di inclusione, nel quale l’eccellenza economica convive con un’esclusione di massa e in cui un’intera generazione rimane intrappolata tra la necessità di indebitarsi per andare avanti e l’impossibilità concreta di liberarsi dai debiti.
23/05/2022 12:05