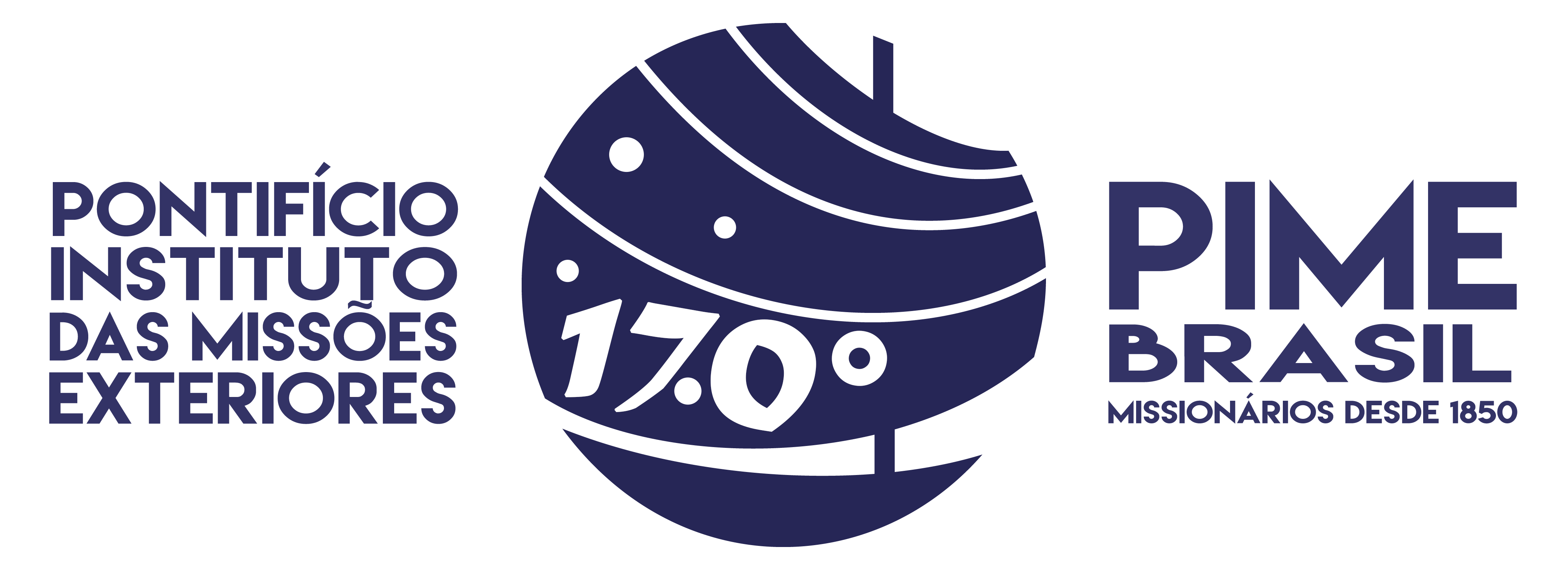Pechino e la trappola dell'esportazione permanente
Nonostante la guerra sui dazi nel 2025 la Cina ha sfondato il tetto dei 1000 miliardi di dollari nel suo surplus commerciale, il cui 45% è generato oggi nel Sud-est asiatico, in Africa e in America Latina. Questa ricchezza non diventa però volano per i consumi interni, perché il calo dei prezzi alla produzione in nome della competitività comprime anche salari e redditi. Un nodo che il nuovo Piano quinquennale in arrivo a marzo non sembra destinato ad affrontare davvero.
Milano (AsiaNews) - La Cina ha registrato nel 2025 un surplus commerciale superiore ai 1000 miliardi di dollari, il più alto mai raggiunto nella storia economica contemporanea. Dai porti cinesi continuano a partire container carichi e i numeri dell’export segnano nuovi record, ma tale straordinario afflusso di entrate non si riflette nell’andamento delle riserve in valuta estera. Queste ultime sono rimaste infatti sostanzialmente stabili, passando dai 3200 miliardi di dollari di fine 2024 a soli 3300 miliardi nel novembre dell’anno scorso. Dove finiscono, allora, questi capitali?
La risposta va cercata in un cambiamento profondo nel modo in cui la Cina gestisce la propria ricchezza commerciale. Se in passato il governo tendeva ad accumulare direttamente le entrate commerciali sotto forma di riserve statali, oggi il sistema è cambiato: una parte consistente dei flussi in entrata resta nelle mani delle imprese esportatrici e prende la via dell’estero attraverso investimenti privati, come le fabbriche di veicoli elettrici in Europa o gli impianti di semiconduttori nel sud-est asiatico. Non si tratta più di singoli progetti infrastrutturali isolati, come nella prima fase della Belt and Road Initiative, ma del trasferimento di interi gruppi industriali che si insediano fuori dai confini nazionali portando con sé fornitori e subfornitori.
Un’altra quota dei capitali viene indirizzata verso strumenti finanziari denominati in dollari, anche se non più verso i titoli del Tesoro americano, che la Cina ha ridotto ai livelli più bassi degli ultimi 17 anni. Imprese e investitori cinesi privilegiano oggi attivi del settore privato, limitando l’esposizione diretta verso Washington, ma continuando a cercare rendimenti sul mercato statunitense. Parallelamente, molte aziende stanno rimborsando debiti contratti in valuta estera oppure scelgono di tenere i loro profitti al di fuori dei confini nazionali.
Tutto ciò ha riflessi concreti sul territorio. Come racconta il New York Times in un reportage da Ningbo, il porto più grande al mondo per volume di merci, le navi salpano senza sosta cariche di merci mentre, a pochi chilometri di distanza, le vie dello shopping appaiono deserte e i negozi registrano un crollo delle vendite, mentre molti residenti sono a corto di denaro. Il surplus commerciale, in altre parole, genera numeri senza tradursi in benessere diffuso e finisce per mettere in luce uno squilibrio strutturale che continua ad accentuarsi.
La trappola dell'esportazione permanente
L’attuale squilibrio affonda le sue radici nell’architettura stessa dell’economia cinese. I consumi delle famiglie rappresentano il 39% del prodotto interno lordo, contro una media del 60% nelle economie avanzate. Si tratta di una distanza molto ampia, che riflette decenni di scelte politiche orientate a favorire investimenti industriali e infrastrutture a scapito del potere d’acquisto delle persone. Ne deriva un sistema che produce molto più di quanto i cittadini siano in grado di assorbire, costringendo il Paese a esportare l’eccesso di beni per tenere in funzione le fabbriche e preservare la stabilità occupazionale.
Nel 2025 questo divario si è ulteriormente ampliato. I consumi interni hanno rallentato, gli investimenti privati sono diminuiti e la spinta fornita dai progetti infrastrutturali ha iniziato a indebolirsi, mentre il settore immobiliare continua a essere in difficoltà per il quarto anno consecutivo, con vendite e investimenti in forte calo rispetto ai livelli precedenti. A ciò si aggiunge una fase deflazionistica che dura ormai da tre anni, alimentata dalla sovrapproduzione. Il calo dei prezzi alla produzione consente alle imprese di esportare a costi sempre più bassi, rafforzando la competitività dei beni cinesi sui mercati internazionali.
Si crea così un circolo vizioso. Il calo dei prezzi interni rende i prodotti cinesi molto competitivi all’estero, ma allo stesso tempo riduce i profitti delle imprese, aumenta il peso reale dei debiti e comprime salari e redditi. Di fronte a un futuro incerto, le famiglie consumano meno, alimentando nuova deflazione e nuova sovrapproduzione, che deve essere assorbita dai mercati esteri. Il governo ha introdotto misure limitate a sostegno dei consumi, come incentivi alla rottamazione e sussidi mirati, ma si tratta di interventi frammentari, insufficienti a cambiare le aspettative.
Pur potendo rafforzare i trasferimenti alle famiglie o la protezione sociale, le autorità continuano a privilegiare gli investimenti pubblici in industrie strategiche e infrastrutture. La ragione è semplice. Finché le esportazioni continuano a crescere, Pechino riesce a centrare il suo obiettivo di crescita economica, fissato al 5% annuo, senza dover affrontare i nodi strutturali. Il successo commerciale internazionale diventa un alibi per rimandare riforme difficili. In altre parole, la forza delle esportazioni si trasforma paradossalmente in un ostacolo al riequilibrio interno.
Una situazione insostenibile
Questo modello mostra ormai crepe sempre più evidenti, poiché sul fronte esterno il protezionismo è in crescita. L’Unione Europea, ad esempio, ha imposto dazi sui veicoli elettrici cinesi e il presidente francese Emmanuel Macron ha definito il surplus di Pechino “inaccettabile”, mentre su un altro fronte molti Paesi in via di sviluppo iniziano a subire la concorrenza di merci vendute a prezzi molto bassi e saranno costretti a difendersi. Secondo alcuni osservatori, il surplus commerciale cinese costituisce oggi per il sistema degli scambi globali una minaccia superiore addirittura a quella dei dazi statunitensi.
Per attenuare queste pressioni, la Cina sta cercando di diversificare propri sbocchi commerciali. Il surplus con i Paesi della Belt and Road Initiative ha superato quello con gli Stati Uniti, arrivando a rappresentare il 45% del surplus complessivo cinese, contro il 24% attribuibile agli scambi con gli Usa. Le esportazioni verso il sud-est asiatico, l’Africa e l’America Latina sono cresciute sensibilmente. Questa redistribuzione geografica, tuttavia, alimenta il sospetto che parte delle merci cinesi raggiunga comunque i mercati occidentali attraverso rotte indirette, aggirando i dazi. Se confermato, il fenomeno potrebbe innescare nuove ritorsioni.
Anche sul piano interno le contraddizioni si accentuano. La Cina ha consolidato la propria centralità produttiva e industriale in settori strategici, dalle terre rare alle batterie per veicoli elettrici, conseguendo risultati tecnologici rilevanti, anche nell’intelligenza artificiale. Al tempo stesso la base sociale di questa potenza industriale appare sempre più fragile. La fiducia dei consumatori è ai minimi storici e il rapido invecchiamento della popolazione si accompagna a un crollo delle nascite, scese nel 2025 al livello più basso dal 1949, segno che il Paese si sta avviando verso una contrazione. Alcuni economisti descrivono la situazione come una forbice che continua ad allargarsi. Da un lato crescono esportazioni e capacità tecnologiche, dall’altro arretrano consumi, natalità e fiducia nel futuro. Il rischio è che si consolidi una mentalità deflazionistica simile a quella che ha bloccato il Giappone per decenni, rendendo sempre più difficile uscire dalla spirale.
Il XV Piano Quinquennale, atteso per marzo 2026, rappresenta un passaggio cruciale. Le bozze finora emerse suggeriscono una forte continuità con le scelte precedenti: innovazione, autosufficienza tecnologica e sviluppo di settori come la robotica e l’informatica quantistica restano al centro. L’obiettivo dichiarato è portare la quota cinese nella produzione globale dal 30% al 40%, mentre lo spazio riservato a un rafforzamento dei consumi interni appare limitato.
Prima o poi, tuttavia, il riequilibrio dovrà avvenire. Le esportazioni non possono crescere senza limiti, soprattutto in un contesto di barriere commerciali crescenti e rallentamento dell’economia globale. Quando questa spinta verrà meno, la Cina si ritroverà di fronte alla necessità impellente di dare maggiore sostegno alla domanda interna senza poter più contare sul traino esterno. Rinviare ancora il riequilibrio significa accettare che la deflazione diventi una condizione permanente, con un conto salatissimo da pagare e un’economia che finirebbe per bloccarsi in una traiettoria senza vie di uscita, con tutte le relative conseguenze politiche e sociali.