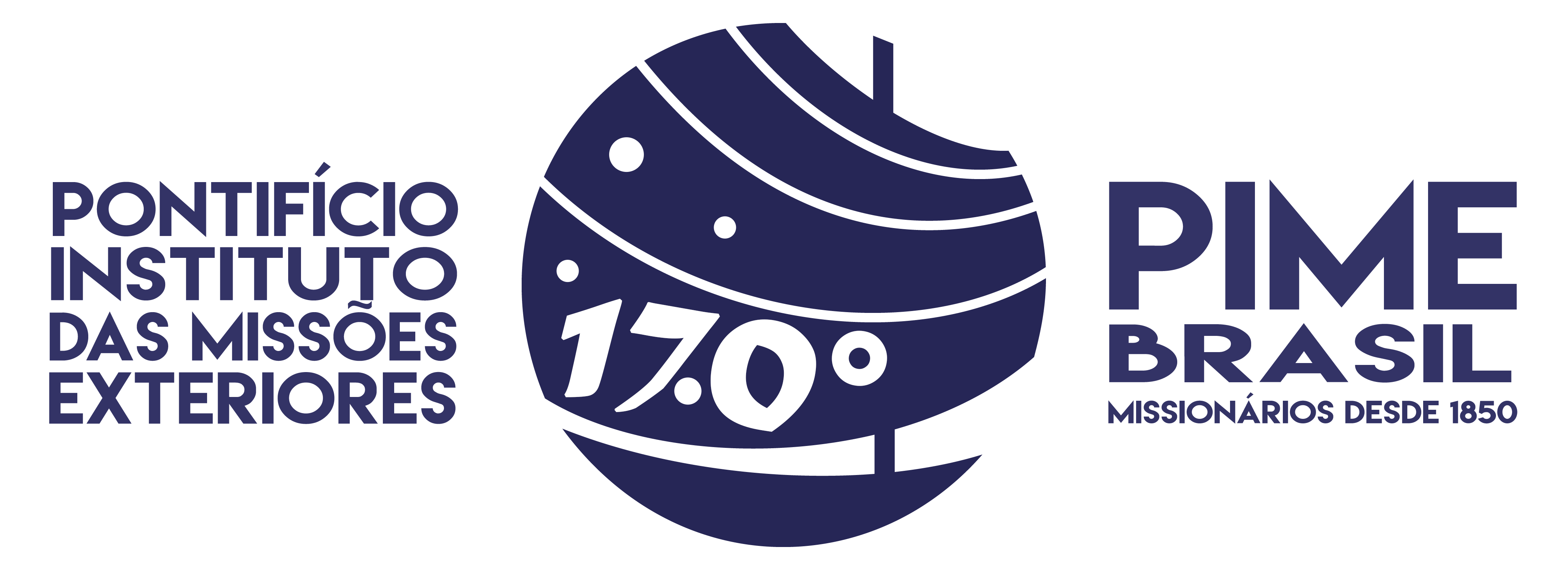L'identità dei russi tra patriottismo e religione
Credere nella Russia non significa automaticamente credere in Dio e nei dogmi religiosi, appartenere alla Chiesa ortodossa non comporta necessariamente frequentare le celebrazioni liturgiche, sostenere i “valori tradizionali” non si traduce automaticamente nell’assunzione dei dettami del catechismo.
In occasione del Giorno dell’unità popolare della scorsa settimana, il centro sociologico del Cremlino Vitsom ha svolto un’indagine sul tema delle priorità per l’affermazione dell’identità dei cittadini russi, domandando a quale gruppo sociale o comunitario essi si riferiscono principalmente, in pratica “Chi siete voi?”. I risultati hanno dato a stragrande maggioranza la risposta patriottica “un cittadino della Russia”, mentre in modo sorprendente agli ultimi posti si è rilevato il riconoscimento di “un fedele della mia religione”, che ha raccolto solo il 2% delle risposte (di fatto la percentuale di russi che frequentano le celebrazioni religiose), ancora meno della risposta “un cittadino del mondo”, che ha ottenuto il 3%.
Una delle affermazioni più comuni, al 60%, riguarda “la Russia come Paese multietnico”, che rende il Paese “molto più forte”, anche se lo scorso anno i sostenitori della “multinazionalità” erano il 5% in più. Gli esperti del Vitsom spiegano che “quando si parla della propria identità personale, la cittadinanza appare sempre al primo posto, superando di molto le altre fondamenta identitarie come il gender, la propria generazione, la professione, l’appartenenza etnica e altro”. Il riconoscimento patriottico è il fattore comune che unisce le persone indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla condizione sociale e dalla regione di residenza o di origine.
La contraddizione più evidente riguarda in effetti il rapporto con la religione, in particolare con il cristianesimo ortodosso. Un sondaggio del Vitsom nel 2019 riportava un 63% di intervistati che si dichiarava convintamente ortodosso, e non è facile spiegare la grande distanza tra identità e appartenenza religiosa dei russi. Molto dipende da come sono formulate le domande, da cui risulta che la confessione religiosa è una componente secondaria dell’identità patriottica, anche per le altre religioni “tradizionali” della Russia come l’islam, il buddismo e l’ebraismo, e i “valori tradizionali” non a caso vengono sempre definiti “morali e spirituali”, inserendo i secondi in dipendenza dei primi, definiti dalle autorità civili e quindi confermati dalla benedizione del pope, del rabbino, del lama o del mullah.
L’appartenenza religiosa dei russi è molto formale, come conferma la scarsa frequenza alle liturgie, spesso vissute più come azione folcloristica in occasione della Pasqua e delle grandi feste, quando ci si reca in chiesa per benedire i dolcetti e i regali da distribuire ai parenti. Perfino la partecipazione alle celebrazioni rispecchia una modalità quasi soltanto esteriore: dei pochi che si recano alla Divina Liturgia, la Messa ortodossa, non più del 10% si accosta ai sacramenti della confessione e della comunione, mentre il resto dei fedeli si limita ad accendere una candela davanti all’icona del santo preferito.
La rinascita religiosa degli anni Novanta, dopo la fine dell’ateismo comunista, ha visto una spettacolare trasformazione di cento milioni di “non credenti” in “devoti ortodossi”, con un’iniziale ricerca sincera di riscoperta dei valori religiosi che ben presto è diventata un processo di votserkovlenie, il termine russo che indica la “chiesificazione”. Il battesimo e il matrimonio religioso sono la massima espressione di questo reinserimento nella vita ecclesiale, che assume poi contenuti particolarmente intensi soltanto accostandosi all’esperienza monastica, vissuta in Russia come una forma radicale di identità con la “Patria terrestre e celeste” nello spirito della “fuga dal mondo” vissuta come “fine del mondo”, non credendo veramente che la vita su questa terra possa essere conforme ai principi eterni della religione.
Per la grande massa dei “credenti ortodossi” russi non contano molto le questioni della salvezza individuale, della vita secondo gli ideali spirituali, degli imperativi morali, tanto meno delle problematiche teologiche. L’Ortodossia è la confessione storica della Russia, e di essa bisogna andare fieri come parte solenne della propria cittadinanza, e questo riguarda anche le altre confessioni, ottenendo un “islam moderato” non per interpretazioni coraniche approfondite, ma per la coscienza di un “islam russo” che non deve essere contaminato da quello radicale proveniente dal Medio Oriente o da altre zone musulmane “non patriottiche”. E questo vale anche per i Paesi dell’Asia centrale a maggioranza islamica, che mantengono un’autocoscienza molto affine a quella dei vecchi padroni imperiali.
Del resto, si calcola dai sondaggi anche una percentuale molto alta di cittadini russi che non indicano alcun riferimento a confessioni religiose, tra il 30 e il 40% almeno dalle statistiche ufficiali, e forse anche di più nella realtà. L’indifferenza religiosa è comune a tante altre popolazioni dei Paesi di tradizione cristiana, in Europa e nel resto del mondo, e per la Russia è un fattore analogo alla modalità di adesione all’ideologia sovietica dello scorso secolo. I funzionari di partito e delle varie istituzioni pubbliche si mostravano devoti ai principi del comunismo per convenienza della scala sociale e delle prospettive di carriera, ma la gran massa della popolazione si conformava ai principi ideologici soltanto per evitare complicazioni, nonostante la martellante propaganda delle lezioni di DiaMat, il marxismo-leninismo dialettico, insieme a quelle anti-religiose di “ateismo scientifico”.
Proprio gli specialisti dell’ateismo sono poi diventati, subito dopo la fine del comunismo, i principali maestri della religione, che affermavano di studiare solo apparentemente per contrastarla, in realtà perché erano i primi ad interessarsene. Questo potrebbe far pensare a un “effetto inverso” anche dell’attuale propaganda patriottica ossessiva, dagli asili alle università e in ogni ambito sociale, che potrebbe rivoltarsi in breve tempo con il mutare degli eventi. Molti sociologi in effetti avvertono che l’attuale conformismo ideologico sia sostenuto fondamentalmente dall’operazione militare in Ucraina, che obbliga alla “mobilitazione delle coscienze” prima ancora che della disponibilità al combattimento, spesso lasciato alle popolazioni minori del Caucaso e della Siberia. Non a caso anche ai tempi sovietici il sostegno più entusiasta alle politiche statali veniva dal mondo dei militari, anch’essi trasformatisi velocemente in servitori del culto, per la facile sintonia tra la guerra e la fede “patriottica”.
Credere nella Russia non significa automaticamente credere in Dio e nei dogmi religiosi, appartenere alla Chiesa ortodossa non comporta necessariamente frequentare le celebrazioni liturgiche, sostenere i “valori tradizionali” non si traduce automaticamente nell’assunzione dei dettami del catechismo. Dipende dalle circostanze e dall’orientamento dei leader politici, sostenuti dai gerarchi religiosi. Si può credere alla “missione divina” della Russia senza avere un’idea precisa della missione evangelica di Cristo e degli apostoli, e questo rende il ritorno della Russia alla religione anche più dannoso della professione dell’ateismo militante. Non a caso gli atei espliciti sono oggi sottoposti in Russia a persecuzioni simili a quelle dei credenti nei tempi sovietici, rendendoli una categoria particolarmente significativa per la difesa della libertà di pensiero e di professione religiosa “al contrario”.
Secondo varie definizioni, che spesso vengono trasformate in capi d’accusa, gli atei sono “amorali” e “indegni della cittadinanza”, si assegna loro una “disfunzione mentale” e la “scarsa capacità di comprensione”, vengono accusati di “vandalismo etico” e di “mancato rispetto alla patria”, "immaginazione febbrile", "licenziosità morale", "adesione al principio di permissività" e altri epiteti simili. Chi si dichiara ateo non è ammesso all’identità russa, perché trasmette “valori non russi ed estranei”, come frutto di propaganda e di predicazione inversa proveniente dai Paesi stranieri, e questo proprio nel Paese che ha realizzato la più grande professione di ateismo in tutta la storia dell’umanità.
Perfino nei Paesi islamici più radicali, nel Medio Oriente e in varie parti del mondo, si lascia maggiore spazio alla libertà di pensiero, pur nella costrizione al rispetto della sharia musulmana, che si limita a mettere in secondo piano i cittadini che non professano la fede musulmana, senza espellerli dalla comunità nazionale, mentre la Russia sembra tornare sempre più verso i tempi bui dell’intolleranza. La religione era per Josif Volokolamskij, il massimo teologo del Quattrocento, la dimensione “istitutrice dello Stato”, espressione molto ripresa oggi da Putin e da Kirill, ma non necessariamente l’istituzione della coscienza e della propria samobytnost, l’identità o “auto-essenza” che si dissolve facilmente nei vortici della storia.
"MONDO RUSSO" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA RUSSIA
VUOI RICEVERLA OGNI SABATO SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK
22/11/2021 08:48