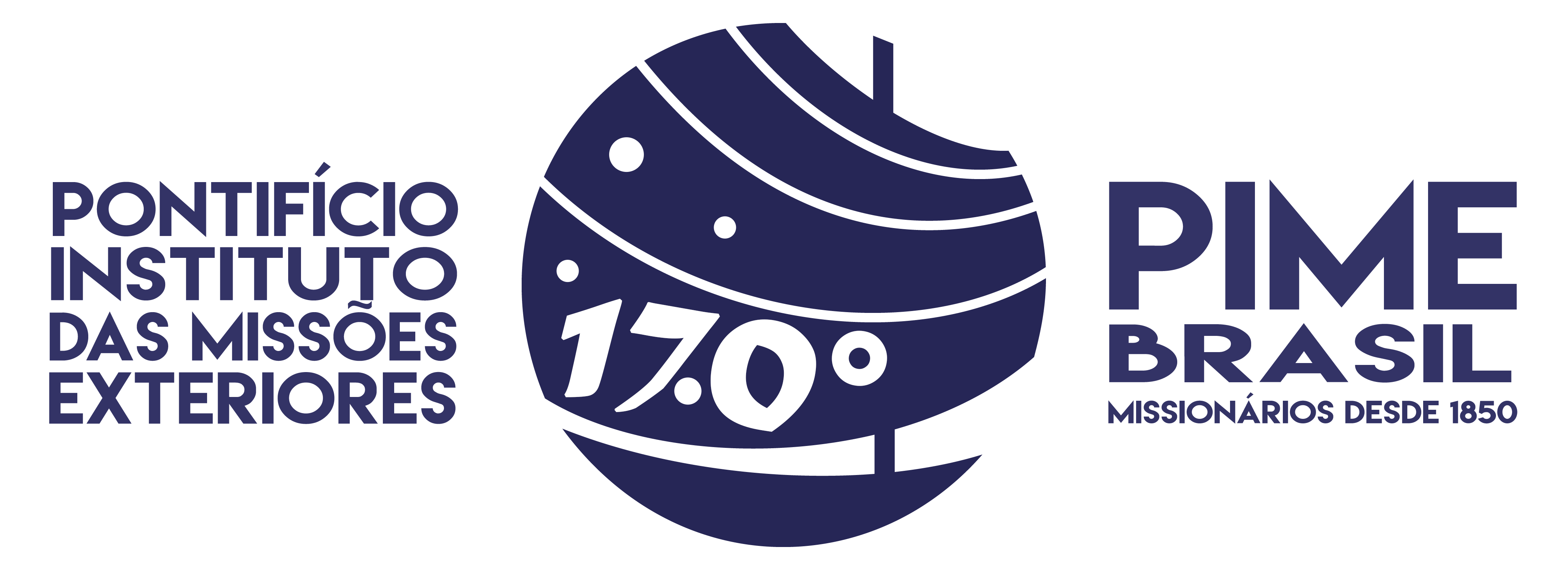Le origini della religione della Russia
Tra la fede ortodossa e il potere esiste un legame essenziale e originario, come mostrava già nell'XI secolo il "Discorso sulla legge e sulla grazia" del metropolita Ilarion, il "manifesto" della fede russa. A parte Filipp II di Mosca, che a fine Cinquecento si ribellò alle carneficine del primo zar Ivan IV il Terribile e venne per questo soffocato nella sua cella monastica, non si conoscono casi di altri oppositori ecclesiastici alle guerre sante dei monarchi.
Una delle questioni più drammatiche e controverse della stagione bellica della Russia putiniana riguarda il suo fondamento religioso, la proclamazione della “guerra santa” da parte del patriarca di Mosca Kirill e della gran parte del clero ortodosso russo, a parte un’esigua minoranza di sacerdoti pacifisti subito emarginati, espulsi dallo stato clericale ed esiliati all’estero. L’impressione è che si tratti di un ritorno alle interpretazioni medievali della guerra di religione tra cristiani e musulmani, con una retorica degna delle Crociate di mille anni fa, e qualcosa di vero in questo sguardo c’è sicuramente, ma non come imitazione russa di un passato latino e occidentale, piuttosto come un ritorno alle proprie origini del battesimo millenario.
Mentre il papa Urbano II teneva la sua omelia per incitare alla conquista di Gerusalemme e della Terra Santa, nel Concilio di Clermont del 1095, la Rus’ di Kiev esauriva il primo secolo della sua storia nelle lotte fratricide dei vari principi, e di lì a poco sarebbe stata sommersa e invasa dalle popolazioni asiatiche e dalle orde mongoliche, uscendo dalla storia per due secoli. La rilettura della storia antica, imposta dai capi di oggi come fondamento imprescindibile per la giustificazione della guerra attuale, si concentra proprio sugli eventi e le testimonianze di quel primo periodo, dal Battesimo di Kiev nel 988 all’invasione dei tartari nel 1240, perché tutti i periodi successivi della storia della Russia di Mosca e San Pietroburgo, e dell’Ucraina di Kiev e Odessa, oltre alla Bielorussia di Minsk e Polotsk, coinvolgendo polacchi, moldavi e rumeni, caucasici e centrasiatici degli imperi zarista e sovietico, dipendono dall’interpretazione del primo leggendario “secolo russo”.
L’antropologo siberiano Roman Šamolin, rettore dell’Università Aperta di Novosibirsk, propone di rivedere il “manifesto della fede russa”, uno dei testi più eclatanti della Rus’ di Kiev, cioè il “Discorso sulla legge e sulla grazia” del metropolita Ilarion, il primo sommo gerarca ecclesiastico di etnia russa imposto dal principe Jaroslav il Saggio nella prima metà dell’XI secolo, senza la benedizione canonica del patriarca di Costantinopoli. Si tratta di un panegirico del principe Vladimir il battezzatore e del “popolo nuovo” e benedetto della Rus’, a confronto con tutti gli altri popoli e quelli di “altra fede”, a cominciare dai “perfidi giudei” secondo la contrapposizione paolina tra il “popolo della Legge” e quello della Grazia che viene da Dio. Ilarion afferma solennemente che “la Legge è passata, ma la grazia e la verità hanno colmato tutta la terra, e la fede si è diffusa tra tutte le nazioni, fino alla nostra nazione russa”.
La polemica anti-giudaica, piuttosto classica nei tempi medievali, si estende in questo testo a tutti i popoli che non hanno riconosciuto Cristo, o che lo hanno in qualche modo tradito, cadendo nell’eresia e regredendo nella fede idolatrica. Così dunque “Dio ha posto la legge per preparare gli uomini a ricevere la verità e la grazia; affinché la natura umana retta dalla legge, rifuggendo il politeismo idolatrico, imparasse a credere nell'unico Dio; affinché l'umanità, come un vaso contaminato, dopo essere stata lavata dalla legge e dalla circoncisione come dall'acqua, potesse accogliere il latte della grazia e del battesimo”. E il battesimo di cui si parla è soprattutto quello di Kiev, il nuovo inizio della storia cristiana, perché “noi non scriviamo per gli incolti, ma per coloro che nutrono un profondo diletto per i libri; non scriviamo per i nemici di Dio, gli eterodossi, ma per i figli suoi; non per gli estranei, ma per gli eredi del regno dei cieli”. La Grazia divina si riflette nell’unica vera Ortodossia, che eleva “gli eredi” russi al di sopra della legge e del peccato, e “la salvezza cristiana è benefica e generosa, poiché si estende a tutti i confini della terra”, e così “benché i giudei fossero prima dei cristiani, i cristiani divennero più grandi dei giudei per la grazia di Cristo”.
Il Discorso di Ilarion si concentra quindi sull’elogio dei potenti, e del grande battezzatore Vladimir di Kiev, il principe “uguale agli apostoli”, estendendo la lode al figlio Jaroslav il Saggio, che sconfiggendo il fratellastro Svjatopolk aveva riportato la pace tra i principati della Rus’. Tra la fede ortodossa e il potere esiste quindi un legame essenziale e originario, la cosiddetta “sinfonia” di tradizione bizantina, ma rivista nella versione “apostolica” russa. “E così è stato: la fede apportatrice di grazia si è diffusa su tutta la terra ed è giunta fino al nostro popolo russo. Le paludi della Legge si sono prosciugate, ma la fonte del Vangelo si è gonfiata d’acqua e ha ricoperto la terra, dilagando fino a noi”, affidandosi alla saggezza dei principi, che saranno in qualche modo comparati o contrapposti al ruolo dei metropoliti e patriarchi soltanto in brevi sprazzi della storia russa. Negli ultimi tempi, il patriarca Kirill ha indicato la strada allo zar Putin solo nei primi anni, per poi sottomettersi alla sua volontà e al suo ardore nel conflitto con i popoli nemici, dell’Occidente invece che dell’Asia antica, ma senza grandi differenze di contenuto.
Come osserva lo storico della Chiesa e teologo più noto della Russia, il diacono Andrej Kuraev, ora esiliato e trasferito alla giurisdizione di Costantinopoli, “in tutto il tempo della Rus’ di Kiev non ci fu un anno senza guerre interne ai principati ed esterne con gli altri popoli, e sono rarissimi i casi in cui i metropoliti cercarono di fare i pacificatori, chiedendo ai potenti di ridurre le proprie ambizioni e abbassare le armi”. La tendenza è stata piuttosto quella opposta, e qualunque conflitto anche nei secoli successivi degli zar è stata giustificato e “benedetto” come difesa della vera fede contro i nemici, come scrive lo storico ottocentesco Nikolaj Kostomarov, ricordando quando il principe Ivan I Kalita, che a metà del Trecento voleva imporre Mosca come il principato dominante, “sollevò tutta la terra russa fino a Novgorod per rivolgersi con le armi contro Pskov, e il metropolita Feognost lanciò contro i nemici la maledizione e la scomunica, benedicendo le armate di Ivan”. A parte il metropolita Filipp II di Mosca, che si ribellò alle carneficine del primo zar Ivan IV il Terribile e venne per questo soffocato a fine Cinquecento nella cella monastica dove era stato rinchiuso, non si conoscono casi di altri oppositori ecclesiastici alle guerre sante dei monarchi della Russia.
Come affermava il metropolita Ilarion, “su di noi si è adempiuto quanto era stato detto dei popoli: Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”. La grandezza della Rus’ era esaltata come quella del popolo chiamato a salvare la terra da ogni male, poiché “Roma eleva lodi a Pietro e Paolo, per mezzo dei quali ha acquistato la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio; l'Asia, Efeso e Patmos lodano san Giovanni il Teologo; l'India loda san Tommaso; l'Egitto san Marco; ogni terra, città e popolo onora e glorifica i suoi maestri, che hanno insegnato la fede ortodossa. Anche noi, dunque, per quanto ne siamo capaci, renderemo una lode, ancorché piccola, al nostro maestro e precettore, che compì gesta grandi e magnifiche, il grande principe della terra nostra Vladimir, nipote di Igor il vecchio, figlio del valoroso Svjatoslav, i quali, regnando al tempo loro, furono famosi per coraggio e valore in molte terre, e sono ancor oggi ricordati e glorificati per le loro vittorie e la loro forza. Infatti essi non dominarono una nazione misera e ignota, ma la nazione russa, che è nota e celebrata per tutti i confini della terra”. In questa memoria universale degli antichi regni cristiani, Ilarion tralascia soltanto l’impero di Costantinopoli e la lode dell’apostolo Andrea, che evidentemente erano stati ormai messi da parte dai russi, avendone assunto le parti nella comunione dei difensori della fede.
Secondo Šamolin “nella religiosità russa c’è un’evidente predominanza della forma sul contenuto, dell’immagine sul pensiero, dell’oggetto sul soggetto, del rito sul sentimento, e della sottomissione al potere al posto di qualunque riflessione sul senso della fede”. In definitiva “un dominio dell’immanente sul trascendente” fin dalle origini del cristianesimo di Kiev, ulteriormente esasperato nella variante moscovita e rimasto anche in quelle successive, dall’impero “occidentale” di Pietro il Grande a quello “ateista” di Josif Stalin, che restaurò le strutture ecclesiastiche per sostenere la guerra contro il nazismo. Qualunque sia il regime al potere, anche quello della democrazia “illiberale” di Vladimir Putin, la garanzia della sua corrispondenza alla storia del “mondo russo” è sempre l’ossequio della religione, rivista secondo i canoni della missione russa nei confronti del mondo intero. Come ricordava Ilarion di Kiev, “se qualcuno non si fece battezzare per amore, lo fece per timore verso colui che lo ordinava, poiché in lui la vera fede si univa all'autorità; allora le tenebre idolatriche presero a diradarsi, e apparve l'alba della vera fede, allora scomparve l'oscurità dell'asservimento ai demoni, e il sole del Vangelo illuminò la terra”.
"MONDO RUSSO" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA RUSSIA
VUOI RICEVERLA OGNI SABATO SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK
16/04/2022 10:30
08/11/2019 11:03